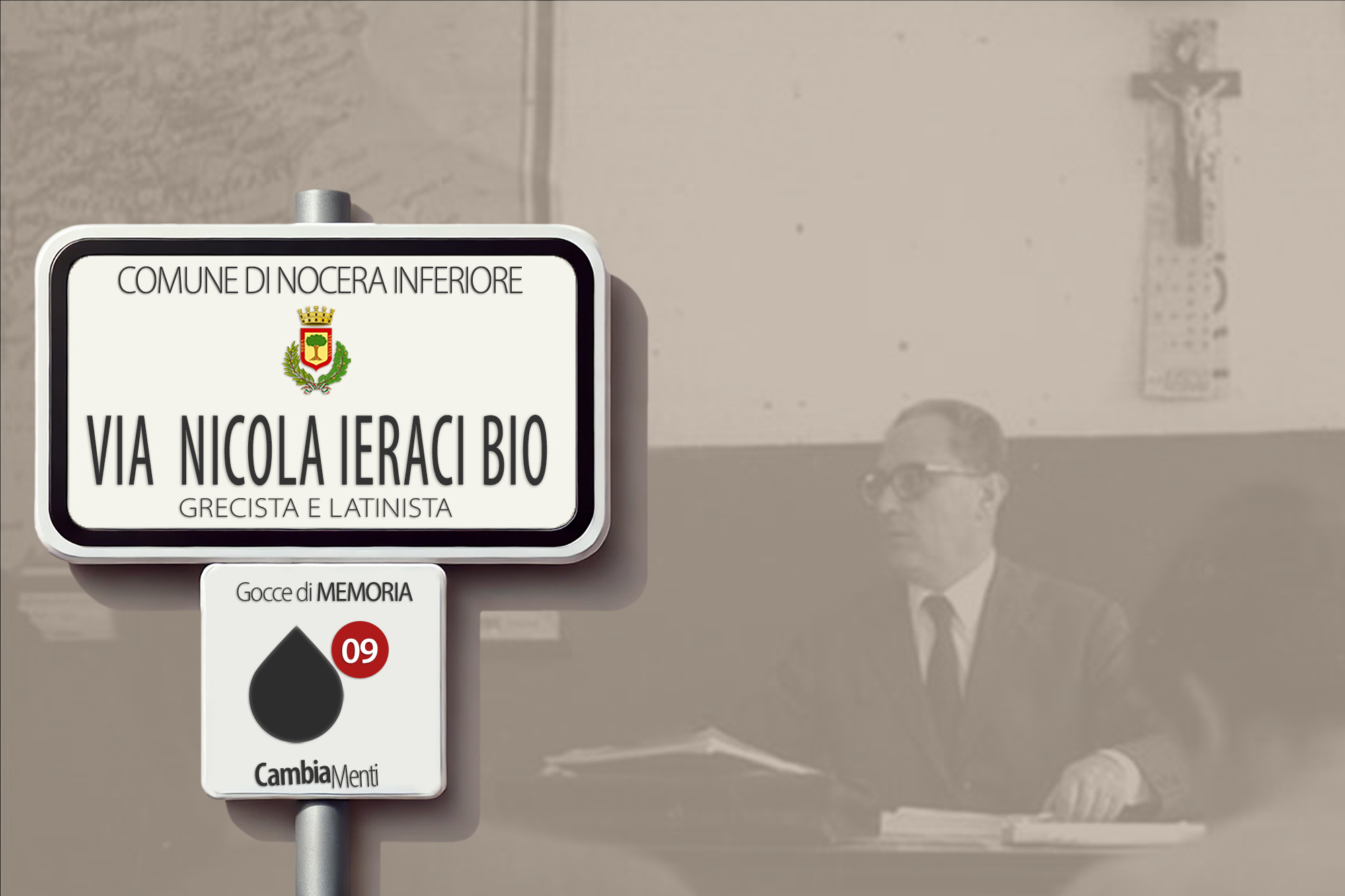Parte III – Dal Manifesto di Ventotene al federalismo europeo, un viaggio attraverso le idee, le sfide e le opportunità di un’Europa unita e sovranazionale.
La storia di un pensiero federalista e di un’Europa sovranazionale, quindi, non è cosa recente e questo è bene comprenderlo. Ventotene, infatti, è il punto finale di un lunghissimo processo storico e di una lunghissima riflessione e di una elaborazione plurisecolare, che si è scontrata con le visioni nazionalistiche e con gli interessi delle esperienze statuali formatisi nell’ultimo millennio. Tappe fondamentali per poter capire la bontà di un progetto federalista.
Ventotene però è la riflessione storicamente più vicina a noi. E senza dubbio alcuno è il catalizzatore della Europa dei nostri giorni, perché si è trovato in quella coincidenza di persone, di società matura, di volontà della classe politica, perché l’Europa è nata dalle macerie e dalle difficoltà ha sempre trovato la linfa vitale per ricrearsi e reagire; a una visione eurocentrica e imperialista, l’Europa del post II guerra mondiale è riuscita a riconfigurarsi e a trovare nei valori democratici e nella tolleranza la propria ragion d’essere e di forza. La fortezza Europa non è una fortezza che si arrocca in se stessa, ma è un baluardo di valori. Per l’appunto, i valori portati avanti da quegli straordinari libri citati di sopra, i valori portati avanti dal “Manifesto di Ventotene” di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, dai “Moniti all’Europa” di Thomas Mann[1] o dagli “Scritti politici sull’Europa” di Luigi Einaudi[2], ideali per i quali pagarono con la vita alcuni martiri laici della libertà europea come Weil, Hayek, von Moltke, Schumpeter, Polny, Hillesum, Stein, Maritain, Popper e Bloch, per citarne solo alcuni, ma anche i tanti ragazzi soppressi a Praga e Budapest per questi ideali dalle barbarie dei regimi dittatoriali o totalitari; una Europa che è un faro dei valori di umanità, civiltà e tolleranza, che guardino al substrato greco-romano della nostra storia comune.
Vedete quanto sia complessa la questione europea, quanto sia necessario studiarla e comprenderla, non fermandosi a una boutade o provocazioni?
Il manifesto di Ventotene, confino fascista nel quale si trovarono Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni, può essere considerato quindi il primo grande contributo della nuova Italia repubblicana alla politica estera. Questo è un contributo che le fece assumere un ruolo di primo piano subito dopo la fine della II guerra mondiale, quando l’Italia era uscita non solo in macerie ma anche in una posizione assolutamente ibrida ed equivoca.
Partendo dall’analisi delle ragioni che avevano provocato due guerre mondiali e ispirandosi contemporaneamente a testi anglosassoni e alle riflessioni di L. Einaudi sulla crisi dello Stato-nazione, il Manifesto di Ventotene[3] abbandonava la convinzione evoluzionista del pacifismo passivo tipica della dottrina liberale – secondo la quale le società erano naturalmente portate a svilupparsi verso forme superiori di convivenza – per aprire una prospettiva diversa di pacifismo attivo, sulla base della necessità di offrire all’Europa il progetto di un nuovo sistema fondato sull’interdipendenza degli Stati e non più sull’equilibrio fra Stati sovrani. In questo senso, la teoria dello Stato federale concepita da Spinelli e Rossi e l’azione politica che ne è stata il suo naturale corollario hanno lasciato il segno nel tempo, collocandosi nel solco del pensiero politico realista.
L’importanza risiedeva nell’analisi di partenza: le nazioni europee, infatti, erano responsabili delle due guerre mondiali e non si erano accorte che, scegliendo la via del conflitto, per ben due volte avevano perso quel primato mondiale acquisito tra Otto e inizi Novecento e favorito la crescita degli Stati Uniti d’America e dell’Unione Sovietica, che erano divenuti ormai gli arbitri assoluti dei destini del mondo. Da ciò derivava la proposta di Spinelli di riunire gli Stati europei trasformandoli da nemici in nemici, affinché potessero opporre la forza del continente europeo, della cultura europea, delle tradizioni democratiche europee alle due superpotenze ed evitare non solo di finire schiacciati, ma anche di costituirsi in un terzo polo e in un’alternativa seria tra i due schieramenti usciti vittoriosi dal secondo conflitto mondiale.
Vi riporto un passo fondamentale riguardante il futuro dell’Europa: Altiero Spinelli non si accontentava solo dell’unione economica ma considerava basilare anche l’unione politica.
“Il problema che in primo luogo va risolto è la definitiva abolizione della divisione dell’Europa in Stati nazionali sovrani. Il crollo della maggior parte degli Stati del continente sotto il rullo compressore tedesco ha accomunato già la sorte dei popoli europei, che o tutti insieme vanno a soggiacere al dominio hitleriano, o tutti insieme entreranno in una crisi rivoluzionaria in cui non si troveranno irrigiditi e distinti in solide strutture statali.
Gli spiriti sono già ora molto meglio disposti che in passato una riorganizzazione federale dell’Europa. La dura esperienza aperto agli occhi anche a chi non voleva vedere ed ha fatto maturare molte circostanze favorevoli al nostro ideale.”
Fondamentale e importantissimo è anche un altro testo di Spinelli, che rappresenta un passaggio successivo e una maturazione rispetto del Manifesto. Siamo già alla fine degli anni ’50, nel 1957, e Spinelli redige un piccolo volume ma dalla dirompente importanza: Il Manifesto dei federalisti europei, che rappresenta un passaggio fondamentale all’interno della costituzione dell’Unione Europea che deve diventare una unione federale dei vari dei vari Stati che devono andarsene amalgamare nella diversità, sempre più cedendo sempre maggiormente quote di sovranità. Vi leggo una parte:
“La divisione in stati nazionali sovrani pesa come una maledizione sull’Europa. Lo sviluppo moderno delle forze produttive e l’intensificarsi dei traffici, l’accelerarsi dai mezzi di comunicazione e di trasporto, il diffondersi di forme simili di civiltà, l’approfondimento del senso di solidarietà umana, esigono ormai da molto tempo l’instaurazione in Europa di una legge e di un governo superiori alle leggi e ai governi degli Stati nazionali. Ma questi sono sovrani. Decidono ed agiscono senza riconoscere nessuna legge, nessun potere superiore a loro. Sono tenuti a provvedere alla tutela degli interessi propri e dei propri cittadini senza avere né il dovere, né la possibilità di preoccuparsi degli interessi di altri Stati e di altri popoli. Tutte le limitazioni e i controlli che il progresso democratico è venuto imponendo ai poteri pubblici concerne esclusivamente la vita interna dei singoli Stati; i rapporti tra Stati sono e continuano ad essere governati dalla legge della giungla. Atteggiamenti e atti di egoismo e di prepotenza che sono considerati come delittuosi sei compiuti da privati o da comunità minori, diventano lodevoli se effettuati da Stati sovrani. Per non aver saputo finora mettere fine a questo regime politico gli Europei sono stati e continuano a essere colpiti da sventure immense e senza fine; l’avvenire loro dei loro figli, dei loro padri, della loro stessa civiltà plurimillenaria diventa ogni giorno più incerto. Per meglio condurre la loro lotta contro questo anacronistico regime, contro gli interessi miopi che lo difendono, contro le menzogne che lo velano i federalisti europei sentono il dovere di esporre con chiarezza il loro pensiero in questo manifesto.”
Parole di una potenza unica, di una forza dirompente e di incredibile attualità. In alcuni passaggi, di questo volume di 68 anni sembra quasi di trovare una eco delle attuali tensioni politiche, della paura di organismi sovranazionali. Ecco l’attualità del Manifesto di Ventotene e dei federalisti europei!
Entriamo nello specifico:
Il Manifesto di Ventotene fu scritto tra il 1941 e 1942, tra le maglie di una rigidissima censura, ma nell’inerzia forzata, nello sfacelo della II guerra mondiale, nell’ora più buia della nostra civiltà europea e occidentale (e ricordate questo aggettivo), in alcune menti lungimiranti – statisti di livello mondiale – andava maturando un processo di ripensamento di tutti i problemi che avevano costituito, come emerge dalla Prefazione di Eugenio Colorni, il motivo stesso dell’azione. La lontananza forzata permetteva uno sguardo più distaccato e consigliava di rivedere le posizioni tradizionali, sentendo il bisogno non di correggere alcuni errori del passato, ma di rienunciare i termini dei problemi politici e – attenzione alla citazione di Colorni – “con mente sgombra da preconcetti dottrinari o da miti di partito”.
Fu così che nella loro mente si fece strada l’idea che la contraddizione essenziale, responsabile della crisi, delle guerre, delle miserie degli sfruttamenti che hanno travagliato la nostra società, in particolar modo l’Europa del post-Secondo conflitto mondiale, fosse l’esistenza di Stati sovrani geograficamente, economicamente, militarmente individuati – punto che ritornerà anche nel Manifesto dei federalisti europei – consideranti gli altri Stati come concorrenti potenziali e nemici, viventi gli uni e gli altri in una situazione di pericolo e di eventuale perpetuo bellum omnium contra omnes.
La soluzione, quindi, non poteva essere che una soluzione internazionalista e ciò che spingeva gli autori ad accentuare in modo autonomo la tesi federalista era il fatto che, per l’appunto, i partiti esistenti erano legati a un passato di lotte combattute nell’ambito di ciascuna Nazione, in quanto avvezzi, per consuetudine e per tradizione, a porsi tutti i problemi partendo, come spesso avviene anche ora, dal tacito presupposto dell’esistenza dello Stato-nazione e quindi dalla domanda di come poter risolvere i problemi del proprio Paese, eventualmente anche a discapito di altri Paesi, o mettendo prima gli abitanti di un determinato Paese rispetto ai viciniori: insomma, privilegiando la vecchia mentalità che ha condotto ai disastri bellici e alla distruzione della vecchia Europa delle potenze che dominava, tra Otto e principi del Novecento, il Mondo intero, con la ricerca di soluzioni immediate e locali e non di visione e interazione a maglie ben più larghe.
Noi siamo abituati ad attribuire al solo Altieri Spinelli e a Ernesto Rossi il “Manifesto di Ventotene”, e loro indubbiamente ne furono i redattori, ma quella che Lucio Levi chiama con una potente espressione la “mensa federalista”, quasi ricollegandosi virtualmente all’idea dei simposi della cultura classica, era composta da Ursula Hirschmann, Dino Roberto, Enrico Giussani, Giorgio Braccialarghe, Arturo Buleghin e Milos Lokar, repubblicani, socialisti, cattolici, sloveni, esiliati appartenenti a vari strati sociali e a varie formazioni partitiche.
Lasciamo il modo nebuloso e non chiaro con cui il manoscritto è uscito da Ventotene ed è arrivato a noi, ma ragioniamo sulla prima edizione a stampa del 1943 sul I volume dei “Quaderni del movimento federalista europeo”. Essa fu curata, probabilmente da Mario Alberto Rollier o da Enrico Giussani, dopo la costituzione del Movimento federalista europeo, avvenuta Milano tra il 27 e il 28 agosto del 1943, nella casa meneghina di Rollier.
Va notato che certi aspetti del Manifesto, rispetto alla prima redazione (quella del 1941-42) erano già superati nel ’43, quando si costituì il Movimento federalista europeo, soprattutto quelli riguardanti la società in Italia. Pertanto, si dovettero riscrivere da capo a fondo e, quindi, il Manifesto di Ventotene non fu discusso e non divenne il manifesto del Movimento federalista europeo.
La seconda edizione, invece, fu pubblicata a Roma nel 1944, mentre la città soffriva dell’occupazione nazista, e Spinelli e Rossi erano in Svizzera dove si erano recati per prendere contatto con gli altri federalisti europei; in genere è questa la versione che noi normalmente leggiamo.
Accanto alla crisi dello Stato nazionale, la seconda fonte del pensiero di Spinelli e Rossi è rappresentata, ma non solo, dal costituzionalismo americano che offre un criterio fondamentale per stabilire mediante quali stadi un processo di edificazione tra più Stati raggiunge il punto di non ritorno.
Gli Stati Uniti d’America, infatti, per l’autore, rappresentano l’esempio di transizione da un sistema di 13 Stati indipendenti, o da una Confederazione, alla Federazione, dimostrando così che solo con la Federazione l’unificazione si consolida e diventa irreversibile; infatti, la Federazione è un nuovo strumento di governo che serve ad assicurare l’unità, e di conseguenza una pace permanente, a un insieme di Stati democratici. Essa, però, costituisce una nuova forma di organizzazione internazionale, e quindi una nuova forma di Stato, che ha origine nel pensiero federalista dei padri fondatori e nel dibattito storiografico di fine ’700, nel caso specifico di Alexander Hamilton[4], che nel The Federalist sostiene che “consiste nell’allargamento dell’orbita entro la quale devono muoversi […] i sistemi popolari di governo civile”.
Infatti, a differenza della Confederazione i cui organi centrali sono subordinati agli Stati membri, la Federazione dà vita a un proprio governo democratico e indipendente che coesiste con i governi degli Stati, pure essi indipendenti nella propria sfera. La Federazione è una nuova forma di Stato che supera, quindi, la forma unitaria e, attraverso la divisione territoriale del potere tra governo federale e Stati federati, istituisce la più forte limitazione del potere statale finora sperimentata e rappresenta la forma più evoluta di governo libero.
Pertanto, il manifesto di Ventotene rappresenta un punto di svolta nella storia del federalismo in quanto è la teoria dell’azione democratica per unificare un insieme di Stati secondo 5 principi fondamentali:
- attualità della Federazione europea;
- priorità strategiche dell’obiettivo della Federazione europee rispetto al rinnovamento dello Stato-nazione;
- spostamento del centro della lotta politica dal piano nazionale all’internazionale;
- costruzione di una forza federalista indipendente come veicolo della battaglia per la Federazione europea;
- assemblea costituente europea come strumento per costituire per costituire un potere democratico europeo.
[1] T. Mann, Moniti all’Europa, Milano 2017.
[2] L. Einaudi, Scritti politici sull’Europa: 1943-1959, III/2, tomo I, Firenze 2020, in particolare il capitolo I/VII, raggiungibile al link: https://www.fondazioneeinaudi.it/approfondisci/edizione-nazionale-scritti-di-luigi-einaudi
Interessanti dati anche da M. Einaudi, Scritti sulla politica europea (1944-1957), Firenze 2013, raggiungibile al link: https://www.byterfly.eu/islandora/object/librib%3A928591#page/6/mode/2up
[3] A. Spinelli, E. Rossi, Il Manifesto di Ventotene, Milano 2017.
[4] A. Hamilton, J. Jay, J. Madison, Il federalista, Bologna 1997, p. 184.