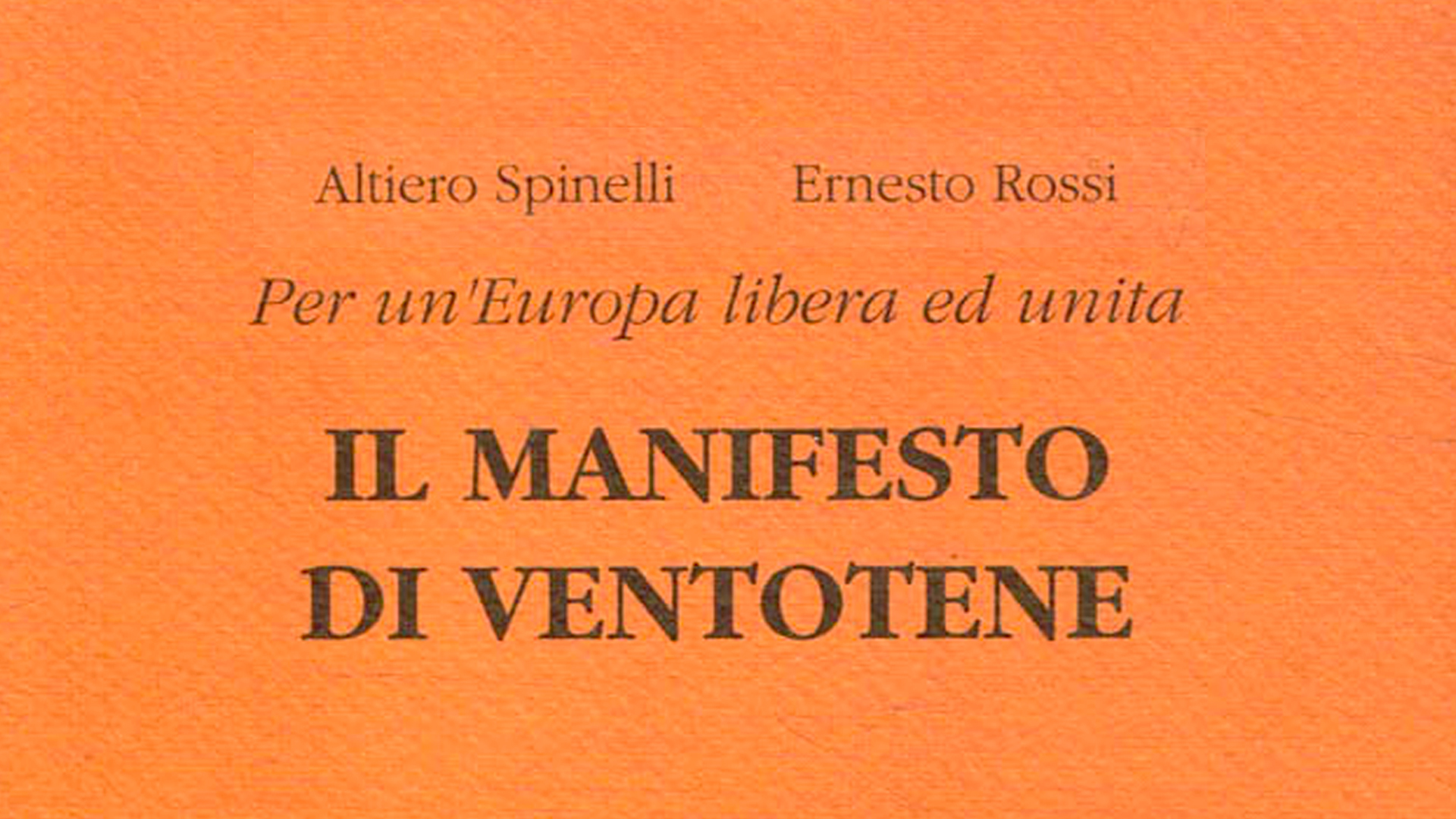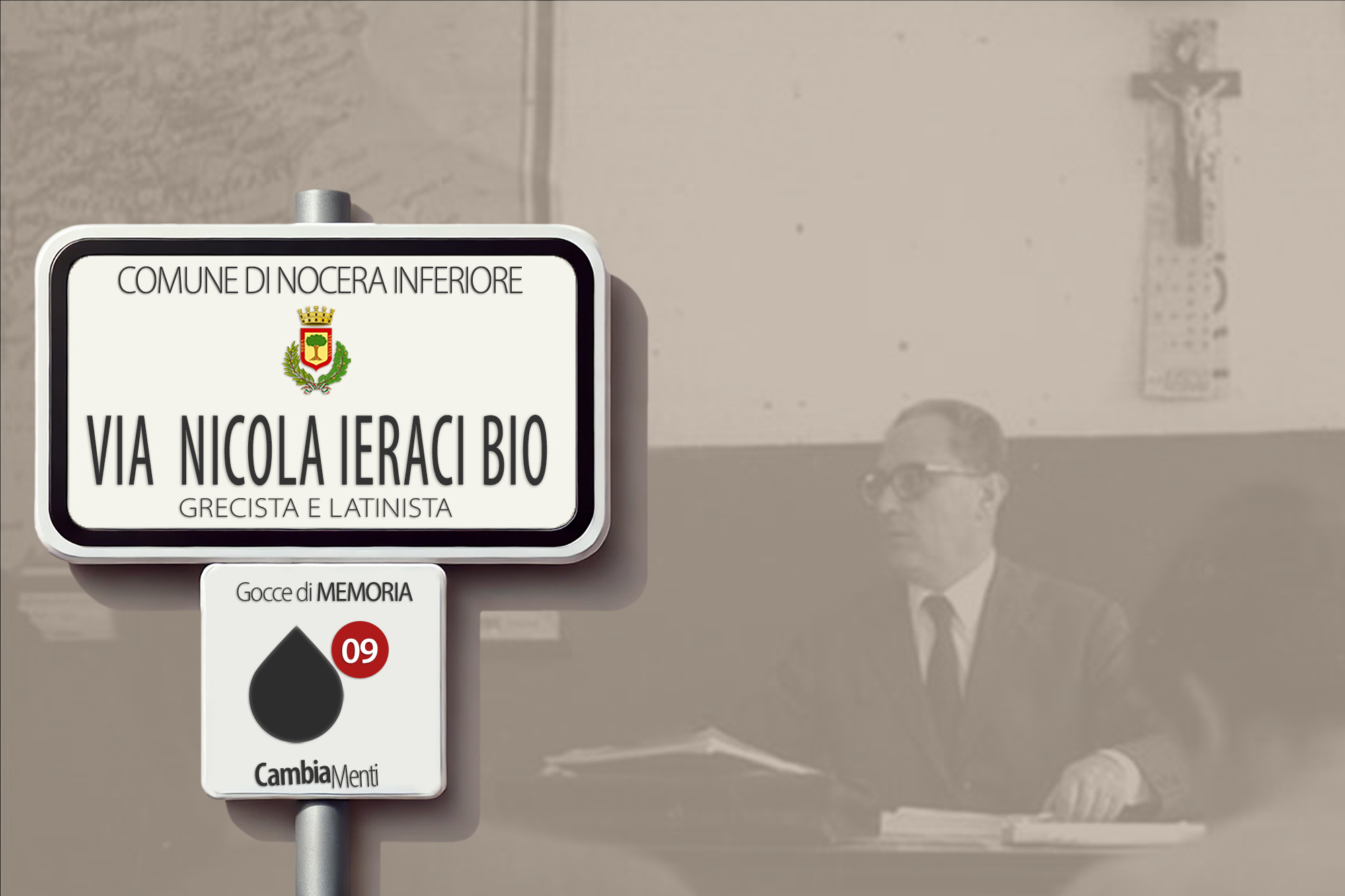Parte IV- Dalle origini medievali al Manifesto di Ventotene, il lungo percorso dell’Europa verso un’unione federale tra sfide politiche, visioni strategiche e opportunità mancate.
Come detto, l’idea federalista non era nuova, e abbiamo visto i vari filosofi che ne hanno parlato dal Trecento ai principi dell’Ottocento, ma è interessante notare che, in maniera diversa ma complementare, ne hanno parlato due persone, completamente diverse tra loro per cultura e formazione, proprio durante la Prima guerra mondiale, quell’inutile strage che ha letteralmente distrutto, più che la Seconda guerra mondiale, l’idea dell’Europa delle grandi potenze e dell’imperialismo europeo. Queste due persone sono Trochij[1] ed Einaudi[2] che lanciano la parola d’ordine, da due poli completamente opposti, degli Stati Uniti d’Europa.
Ma qual è il valore aggiunto del Manifesto di Ventotene?
É che Spinelli, a differenza degli altri che avevano scelto la strada federale, afferma l’idea della ‘attualità’ della Federazione europea; una espressione che ricorda gli studi di Lukàcs[3] su Lenin e sulla sua visione proletaria rispetto agli altri marxisti, ma che Lucio Levi[4], una delle menti più lucide del federalismo europeo, usa per far vedere quanto secondo Spinelli non solo è necessario ma è possibile ricostruire l’Europa su basi federali, per aprire poi la strada alla unificazione di questo macro-governo che dovrebbe essere ipoteticamente un unico governo a livello planetario.
Ciò che caratterizza il federalismo di Spinelli e lo differenzia dagli altri ‘utopistici’ sta nel fatto che egli ritiene impossibile avviare la realizzazione del disegno federalistico senza prima aver abbattuto i partiti politici nazionali e le sovranità nazionali, allontanandosi dal ‘federalismo integralista’ della ‘crisi di civiltà’ di Alexandre Marc[5], Denis de Rougemont[6] e Adriano Olivetti[7], che volevano una riforma globale della società, e distinguendosi per una concezione non solo istituzionale, ma anche economica, sociale e filosofica del federalismo della ‘crisi dello Stato’.
Abbiamo visto l’importanza della riflessione di Alexander Hamilton e del The Federalist per Spinelli e per il gruppo di Ventotene ai fini progettuali di un’azione democratica che ha come scopo la creazione di un nuovo potere che si deve formare per libera scelta di popoli, che devono essere capaci di disarmare le nazioni.
Ma accanto alle studiatissime radici americane del federalismo di Ventotene è interessantissimo, però, notare anche le radici britanniche del federalismo di Spinelli e Rossi.
Queste radici inglesi, in genere, sono un poco sottovalutate, forse perché l’Inghilterra contemporanea ha perso memoria dei propri pensatori europeisti (famosa la frase di Churchill a proposito del Regno Unito che era of Europe but not in Europe) la sua longue durée è ben più ricca e meno provinciale di quanto lo sia oggi e la genealogia imperiale è all’origine di un rapporto ben più complesso con l’idea di Stato-nazione.
Certamente, anche la Gran Bretagna si è macchiata di colpe nazional-imperialiste, ma il suo fondamento storico è il principio della ‘nazione territoriale’ (è preminente la scelta dello spazio e dei confini entro i quali amalgamare e organizzare diverse culture e regioni), non della ‘nazione etnico-linguistica’ (preminenti sono etnia, lingua e religione): è una suddivisione essenziale e prioritaria, teorizzata dallo storico polacco naturalizzato inglese Lewis B. Namier. Non stupisce, quindi, che i federalisti di Ventotene abbiano cercato proprio lumi lì, più che in Italia o nel continente.
Sin dal primo dopoguerra, infatti, Einaudi diffuse questo pensiero europeista formatosi in Inghilterra tra ’800 e ’900 e i suoi testi approdarono a Ventotene influenzando notevolmente prima Rossi, che di Einaudi si considerava allievo, e poi Spinelli.
Una pluralità di fonti e di culture eterogenee che converge su Ventotene, una pluralità di esperienze che hanno reso perciò fondamentale il Manifesto di Ventotene, in quanto punto di arrivo di una serie di correnti di studi e di riflessioni avute nel corso di secoli e punto di partenza e catalizzatore di un ripensamento politico e di una rifondazione totale e completa dell’Europa.
Certo, il processo non è pienamente compiuto ed è un processo storico ancora in corso perché unico nel suo genere. Oltre agli autori citati, ovviamente un ruolo essenziale nella costituzione di questa Europa lo ebbero Monnet, Pleven e Schumann tra i tanti, però le loro proposte e i loro piani (cioè, la CECA e la CED) furono visti in maniera un po’ timida da parte del gruppo federalista; per la Comunità europea di difesa, Spinelli denunciò la contraddizione lampante di creare un esercito europeo di difesa senza un governo europeo. E solo con il concorso di De Gasperi[8], di cui si guadagnò il consenso, e grazie all’iniziativa del governo italiano, Spinelli riuscì a mettere in moto un processo costituente con il conferimento all’Assemblea allargata della CECA del mandato di elaborare lo Statuto della Comunità politica europea, l’organismo politico necessario a controllare l’esercito europeo.
Quanto questa idea federalista sia incompiuta ce lo dicono i fatti e la situazione attuale e ce lo spiegano in maniera molto significativa Lucio Levi e un bel pamphlet di Barbara Spinelli[9] poiché l’Europa che noi siamo abituati vedere si è costituita dopo la Guerra dei trent’anni, con la Pace di Westfalia, organizzandosi in stati sovrani che non riconoscevano nessuna autorità superiore. Non è che siamo molto lontani dalla situazione geopolitica attuale dove notiamo boutade politiche che vogliono allontanarsi dalle organizzazioni sovranazionali.
E, come ha scritto Barbara Spinelli, solo se l’Europa osa e diventa lo spazio dove si organizza la politica e la discussione democratica, diventando quindi una istituzione intermedia fra Stati e mondializzazione, fra cittadini dotati di peculiarità e mercati anonimi, ciascuna nazione potrà ridiventare padrona di sé; insomma l’autrice propone, sulla scia di Ventotene, una Europa più forte, con regole rigorose, ma queste devono essere necessariamente nuove, collegandosi con quanto scritto nel “Manifesto di Ventotene” quando, nel capitolo “Gli Stati Uniti d’Europa e le varie tendenze politiche”, si dice “La federazione europea sarebbe la garanzia del cosmopolitismo intellettuale e della possibilità per l’alta cultura di esercitare la sua funzione di guida”.
Quale la difficoltà?
Il principale ostacolo, ieri come oggi, viene dal fatto che l’Europa non ha alle spalle tradizioni sovranazionali forti: l’età degli imperi era già tramortita nel Seicento prima di perire definitivamente con la pace di Westfalia del 1648 e l’architettura sovranista e nazionalista. Certo, non erano mancate prima forme statuali confederative e trans-nazionali, che per Zygmunt Bauman[10], in “L’Europa è una avventura”, furono la vera alternativa al sistema westfaliano, come la Costituzione polacco-lituana (che, per inciso, includeva larga parte dell’Ucraina e dal Baltico arrivava al Mar Nero) o, prima, la Kyivs’ka Rus (e si vede quando deboli siano le pretese putiniane e basterebbe rileggere un classico come Vernandsky[11] sulle origini dei Rus’, o un recente libro di Plokhy[12], “Le porte d’Europa”, a proposito della storia di quella parte d’Europa). O vi erano stati tentativi come la creazione della duplice monarchia austro-ungarica, crollata con tutto ciò che ne è conseguito dopo la I Guerra Mondiale. Eccezione è la Svizzera per le federazioni democratica; ma questa via federativa, come notato dal “Manifesto di Ventotene”, fu imboccata con successo fuori dall’Europa, come in America del Nord, Australia, Canada, Nuova Zelanda, mentre nel Vecchio Continente prevalsero Stati autoreferenziali il cui pesante freno dura ancora oggi, come notato dallo storico Namier, al quale Einaudi, Rossi, Spinelli e tutto il gruppo federalista di Ventotene guarderà con ammirazione.
[1] L. Trockij, Der Krieg und die Internationale, München 1914, pp. 3-6.
[2] L. Einaudi, Il dogma della sovranità e l’idea della Società delle Nazioni, in «Corriere della Sera», 28/12/1918.
[3] G. Lukàcs, Lenin, teoria e prassi nella personalità di un rivoluzionario, Torino 1970, pp. 11-16.
[4] L. Levi, Il pensiero federalista, Roma-Bari 2002.
[5] A. Marc, Proudhon, Paris 1945; L’Europe dans le monde, Paris 1965; R. Aron, A. Marc, Principes du fédéralisme, Paris 1948.
[6] D. de Rougemont, Vingt-huit siècles d’Europe. La coscience européenne à travers les textes d’Hésiode à nos jours, Paris 1961; L’avenir est notre affaire, Paris 1977.
[7] A. Olivetti, L’ordine politico delle Comunità, Milano 1946; Società, Stato, Comunità, Milano 1952; Città dell’uomo, Milano 1960.
[8] M. Albertini, La fondazione dello Stato europeo. Esame e documentazione del tentativo intrapreso da De Gasperi nel 1951 e prospettive attuali, in «Il federalista», XIX (1977), pp. 5-55.
[9] B. Spinelli, La sovranità assente, Milano 2014.
[10] Z. Bauman, L’Europa non è un’avventura, Roma-Bari 2012.
[11] G. Vernandsky, le origini della Russia, Firenze 1965.
[12] S. Plokhy, Le porte d’Europa. Storia dell’Ucraina, Milano 2022.