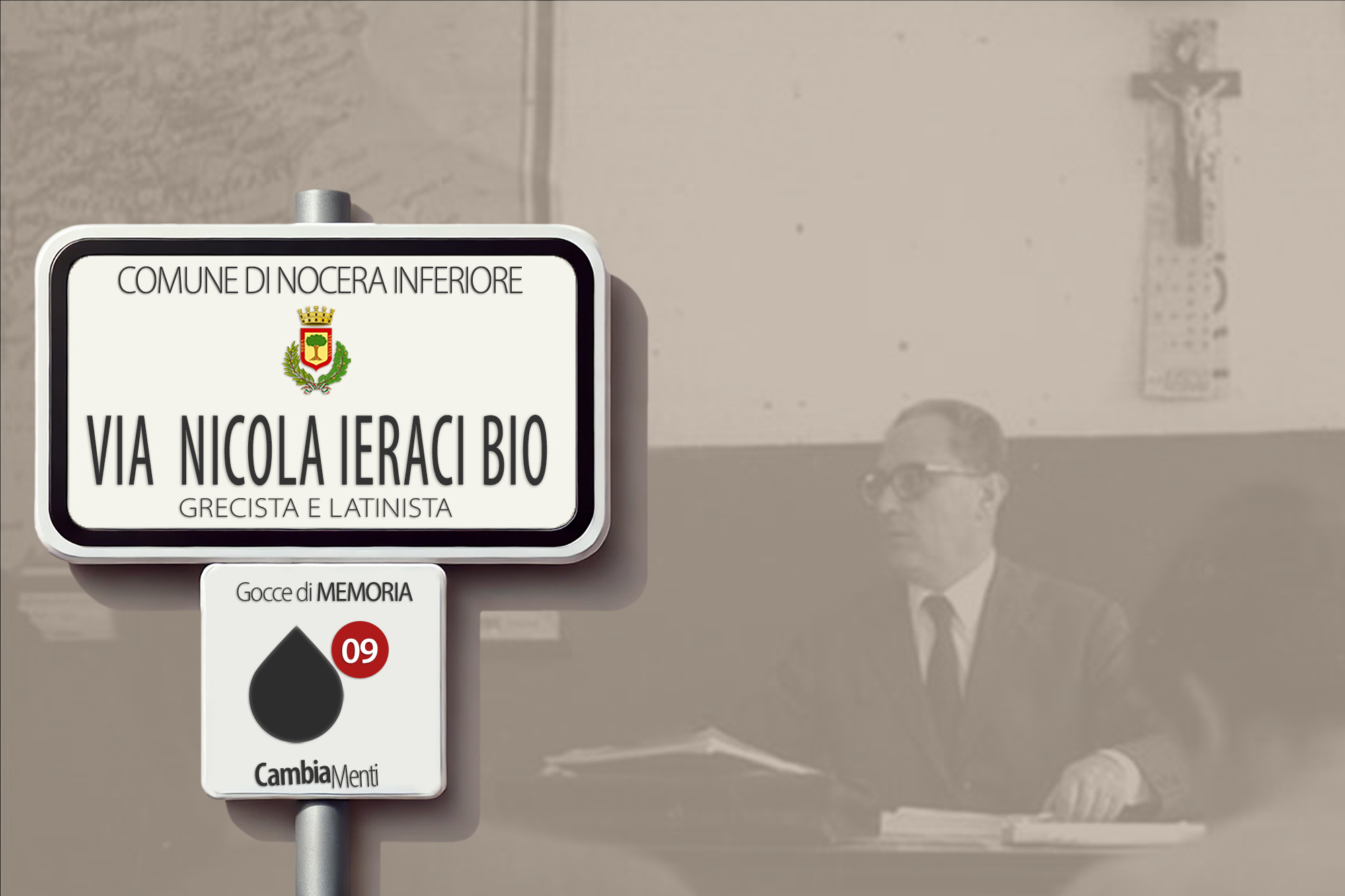Parte II – Dai primi progetti medievali ai federalisti di Ventotene, un viaggio attraverso le idee, le battaglie e le visioni che hanno costruito il concetto di cittadinanza europea
Chiarito dell’esistenza di una coscienza europea sopranazionale, capiamo perché nazionalismo ed europeismo siano completamente differenti e ci porti lontano dal nostro discorso, come ebbe a dire Denis de Rougemont con una battuta.
Denis de Rougemont fece parte del personalismo francese tra le due guerre, dove matura le sue convinzioni europeiste e federaliste, partecipando alla fondazione dell’Unione Europea, relatore della Commissione culturale del congresso a L’Aja nel 1948, fu presidente della I tavola rotonda del Consiglio d’Europa del 1952 e creatore e direttore del Centro Europeo di Cultura da cui ha preso origine il CERN.
Per aprire la sua “Lettera aperta agli Europei”[1], del 21 febbraio 1970 de Rougemont inizia da Albanesi! E finisce con Yugoslavi!, l’autore si sofferma su due punti essenziali con due argute battute:
- la necessità della semplificazione “perché non potremo mai fare nulla insieme se ogni volta dobbiamo iniziare elencandoci nei due generi e secondo l’ordine alfabetico, il che richiede più di ottanta parole di saluto prima di dire qualcosa e dà solo un’idea vaga dei fastidi e degli ostacoli, delle perdite di tempo e di energie che comporta l’esistenza dei nostri Stati-Nazione […]. Lasciatemi quindi dire semplicemente a voi: Europee, Europei!
- Il superamento della mera idea nazionalistica, con la famosa battuta per la quale il generale De Gaulle non sarebbe mai potuto diventare il primo presidente d’Europa, appunto perché non avrebbe mai accettato di iniziare i suoi discorsi con nient’altro che “Albanesi!” e così via. Era e rimane convinto che l’unica realtà che conta sia quella nazionale.
E chiarisce cosa debba divenire l’Unione Europa perché è “l’unica autorità capace di salvaguardare la vostra identità nazionale e regionale, il vostro modo di essere diversi, il vostro modo di rimanere voi stessi”.
E abbiamo visto quanto sia di lunga durata la volontà universalistica europea, che prende nuovo vigore nel Trecento con gli appelli di Pierre Dubois[2], giurista di Filippo il Bello, nel De recuperatione Terrae Sanctae, dove si appella a tutti i principi europei per unirsi; o al re di Boemia Giorgio di Podiebrad[3] che presentò ai sovrani europei una proposta espressa in 21 articoli, per la creazione di un’istituzione superiore agli Stati, attraverso la quale risolvere pacificamente i dissidi; o a papa Pio II[4], che nel De Europa si sofferma sulla base di una comune identità da un lato religiosa (Europa come Repubblica cristiana), dall’altro civile e culturale. Tra XVII e XVIII secolo, Émeric Crucé o Émeric de la Croix[5] pubblica il Nouveau Cynée; il Nuovo Cinea fa riferimento a Cinea, consigliere di Pirro, il quale fece presente al suo re che per godersi la tranquillità della vita non aveva bisogno di imbattersi in guerre di conquista.
Nel Nuovo Cinea, Crucé suggerisce di creare un’assemblea composta da tutti i sovrani della terra, e che dovesse avere il compito di aggiudicare in maniera pacifica le controversie tra stati. Crucé suggeriva che questa assemblea potesse aver sede a Venezia, in quanto porta di contatto tra l’Europa cristiana e l’Oriente. Suggeriva anche che l’Assemblea potesse essere presieduta dal papa, ma assegnava al Sultano il compito di vicepresidente.
Il progetto di Crucé fu ripreso e sviluppato dall’abate di Saint-Pierre e dagli altri autori dei progetti di pace perpetua. La proposta è spesso ritenuta una antesignana dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
Ma è importante anche il Grand Dessein del duca di Sully , ministro di Enrico IV che presenta il progetto di una “Repubblica cristiana” (addirittura “cristianissima” all’interno del testo) universale capace di garantire la libertà di culto delle tre principali confessioni cristiane (cioè cattolicesimo, luteranesimo e calvinismo). Sarebbe stata garantita inoltre la libertà di commercio per tutti e 15 gli Stati membri di nuova fondazione, tripartiti secondo le loro differenze istituzionali (monarchie elettive, monarchie assolute e repubbliche). La nuova Repubblica universale sarebbe stata retta da un Consiglio generale a cui si sarebbero affiancati i vari Consigli particolari competenti per aree regionali. Sarebbe stato costituito un esercito capace di imporre le decisioni prese a maggioranza agli Stati refrattari.
Ma nella riflessione dei federalisti di Ventotene sono fondamentali anche l’Essay on the Present and Future Peace of Europe di William Penn[6], fondatore di uno Stato negli USA, o i Progetti di pace perpetua dell’abate di Saint Pierre[7] e di Immanuel Kant[8] o il volume di Henri de Saint-Simon[9], del 1815, Della riorganizzazione della società europea, o della necessità di radunare i popoli d’Europa in un solo corpo politico, conservando ciascuno la propria indipendenza nazionale, certamente influenzato dall’universo settecentesco nella ricerca di un ordine politico assoluto e universale e nella sconfinata fiducia nel progresso della scienza.
Tuttavia, la riorganizzazione della società europea si proietta sulla realtà contemporanea per l’importanza conferita all’esigenza di riformulare la nozione di sovranità, sottraendole l’alone di sacralità che la circonda, e di costruire il personaggio del tutto nuovo del cittadino europeo consapevole dei benefici della duplice appartenenza a un ordine nazionale e a uno che lo trascende.
Monumenta Europeae Historica che ci fanno capire quanto la questione sia complessa, di lunghissima e plurisecolare genesi e quanto sarebbe opportuno ricreare scuole di partito per la formazione di una classe politica seria e preparata, perché la legge non ammette ignoranze e il politico deve essere ben formato all’ars gubernandi e con una coscienza della fenomenologia storico-politica: e la storia federalista europea è essenziale per la classe politica, perché queste sono questioni politiche e non semplicemente partitiche. E vedremo il perché con le parole di Altiero Spinelli e degli altri europeisti, perché l’Europa non è appannaggio di un partito o di un altro.
[1] https://ilpensierostorico.com/lettera-aperta-agli-europei/?print-posts=pdf
[2] Pierre Dubois, De recuperatione Terrae Sanctae, a cura di A. Diotti, Firenze 1977.
[3] R. Repetti, La genesi del progetto di unione europea di Giorgio di Poděbrad e Antoine Marini: il Memorandum ad procedendum magnanime contra Turcum (1662), in «Eurostudium» 1 (2018), pp. 2-14.
[4] Enea Silvio Piccolomini, De Europa (1458-1461), Roma 2024.
[5] Émeric Crucé, Il nuovo Cinea per una pace universale, a cura di A.M. Lazzarino Del Grosso, Napoli 1979.
[6] William Penn, Essay towards the Present and Future Peace of Europe, in Political Writings, Cambridge 2020, pp. 344-362.
[7] Charles-Irénée de Saint Pierre, Scritti politici. Per la pace perpetua e sulla polisinodia, Lecce 1996.
[8] Immanuel Kant, Per la pace perpetua, Milano 2024.
[9] Henri de Saint-Simon, Della riorganizzazione della società europea, o della necessità di radunare i popoli d’Europa in un solo corpo politico, conservando ciascuno la propria indipendenza nazionale, Roma 2019.